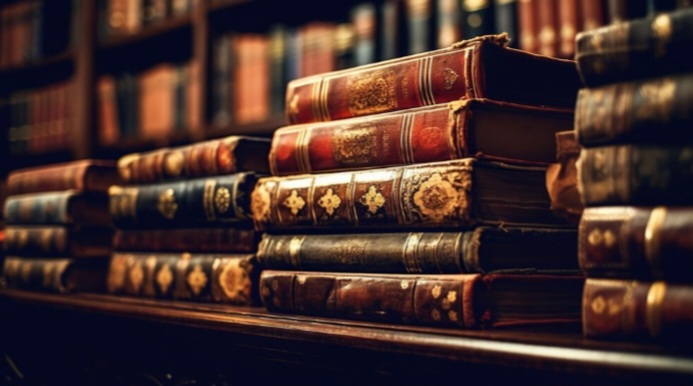
Non saprei indicare un momento preciso in cui è cominciato tutto. A volte penso che la passione per la lettura, e in particolare per la filosofia, non sia nata per un motivo specifico, ma sia sempre stata lì, come un bisogno silenzioso che ha trovato forma lentamente, libro dopo libro, giorno dopo giorno, accompagnandomi nella mia crescita, non solo quella anagrafica. Credo proprio di non aver scoperto l’importanza che aveva per me la filosofia studiandola a scuola, ma sono certo che mi ci sono avvicinato non per obbligo, come un qualcosa che cercavo altrove, ai margini dei programmi e delle scadenze. Un incontro nato per conto mio, con un ritmo mio, apparentemente senza aspettative da soddisfare.
Con il tempo ho capito che non cercavo solo idee da imparare, ma parole che sapessero accompagnarmi. Non tesi, ma un tono. Un modo di stare al mondo. Così, pagina dopo pagina, la filosofia ha cominciato a diventare qualcosa che non si limitava alla lettura, ma si introduceva nella vita quotidiana, nella maniera di osservare le cose, di sentire il tempo che passa, di affrontare le piccole e grandi contraddizioni dell’esistenza.
Alcune letture hanno avuto un peso particolare. La Repubblica di Platone, l’Apologia di Socrate, le Lettere a Lucilio di Seneca, Freud, per citarne alcune. In quei testi, e più in generale nella lettura dei Greci, ho sentito per la prima volta con chiarezza il senso del limite, la tensione verso il sublime, il confronto tra l’apollineo e il dionisiaco. Non li ho mai vissuti solamente come testimonianze di un passato da studiare, ma come presenze attuali, capaci di parlare ancora all’oggi e a me. Mi accorgo col tempo che mi hanno insegnato che pensare non dovrebbe essere un’attività astratta, ma una forma di ascolto. Che cercare il senso non significa arrivare sempre a una risposta, ma imparare a reggere la domanda. In quel movimento ho sentito qualcosa di profondamente umano, e anche profondamente bello.
La lettura stessa è diventata, negli anni, un gesto quotidiano, necessario. Una specie di rituale silenzioso, una zona franca, una dimensione. Non leggo per distrarmi, ma per ricordarmi qualcosa, una sorta di vigile oblio, spesso non saprei definirlo con esattezza. Forse che siamo finiti, eppure capaci di pensiero infinito. Che non possiamo sapere tutto, ma possiamo continuare a chiederci. E che in quella tensione si nasconde una forma di libertà.
Alcuni autori, incontrati in momenti diversi della vita, sono diventati compagni silenziosi. Nietzsche, una presenza costante, un richiamo continuo a pensare, a far risuonare le idee come corde tese. Kierkegaard, una vertigine della scelta. Schopenhauer, illuminante, un continuo dare senso e significato alla quotidianità. Proust, immenso, un continente da esplorare costantemente. E poi Roth, Auster, Zola, Boudelaire, Whitman, Marquez, e gli immancabili russi, Dostoevskij, Tolstoj, Gogol, letture che hanno affondato radici nella parte più sensibile del mio animo, dove si confondono introspezione, destino, storia, solitudine. Non si tratta semplicemente di seguirli, né di condividerli in tutto, ma di lasciarsi toccare da qualcosa che continua a dire, anche quando non si capisce subito cosa. Qualcosa che resta, pagina dopo pagina, giorno dopo giorno.
E poi sempre loro, tra i primi che ho incontrato e a cui sempre torno: Socrate, Platone, Epicuro, il dialogo, il paradosso, l’ambiguità. In ogni testo, sento la stessa tensione: il bisogno di verità e la consapevolezza della sua inafferrabilità. Ogni incontro lascia una traccia, anche quando non ce ne si accorge subito. A volte è solo un’immagine, un’intonazione, una frase che resta. Ma quella frase, nei momenti giusti, riemerge e mi orienta.
Nel tempo ho iniziato a vedere tutto questo come una forma di estetica dell’esistenza. Non nel senso di un abbellimento, ma di una cura, a volte una sorta di terapia. Un modo di abitare meglio il pensiero, e quindi anche la vita. Non si tratta di coltivare opinioni forti, né di diventare esperti. Si tratta, forse, di rallentare, di sostare dove altri corrono. Di dare valore alla complessità, e di non farsi spaventare dal fatto che non tutto si tiene insieme perfettamente in queste nostre vite.
Anche per questo non ho mai pensato alla filosofia solo come a un sapere da possedere, ma più come a un compagno di viaggio, qualcosa che cammina con me. E così la lettura è diventata, nel tempo, più di un hobby o una passione: è diventata il luogo in cui mi riconosco. Un paesaggio interiore in cui tornare, non per fuggire dalla realtà, ma per ritrovarla, continuamente.
Ci sono giorni in cui mi accorgo che non potrei davvero vivere senza questa dimensione. Non per una questione esclusivamente intellettuale, ma perché leggere e pensare sono per me un modo di respirare, di vivere, una forma di radicamento, una fedeltà a qualcosa che non so definire ma che sento essenziale.
La lettura mi ha sempre dato uno spazio in cui essere senza dover apparire, senza dover spiegare. Sento che ha affinato la mia sensibilità al dettaglio, all’ambiguità, al non detto. Ha tenuto viva una tensione tra il bisogno di senso e la bellezza del non sapere. È stata una costante, un ritmo sotterraneo che ha accompagnato ogni giorno, anche quelli più stanchi, più difficili, ma anche quelli più belli, indimenticabili, stimolanti. I libri mi hanno sempre atteso, e io li ho sempre cercati. E la filosofia, pur non essendo sempre al centro, non se ne è mai andata davvero. Ogni volta che l’ho cercata, era lì.
In fondo, ogni volta che torno a leggere quei testi, antichi o moderni, conosciuti o marginali, sento di tornare anche a me stesso, pagina dopo pagina, giorno dopo giorno.