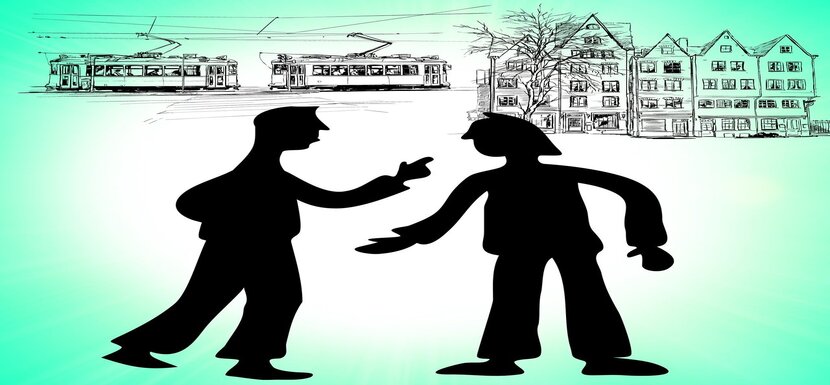
La distruzione del sistema, quello che lo precede cronologicamente o quello dell’avversario. Per distruggere un sistema basta poco: è sufficiente trovare quel minimo particolare che, inevitabilmente, fa crollare tutto l’apparato.
Dei filosofi in fondo ho sempre ammirato l’attitudine critica che, spesso, si esercitava come arte della distruzione.
Il principe della destabilizzazione era il Socrate dei dialoghi Platonici, fortissimo a demolire i suoi avversari, rigoroso e formidabile, attraverso l’ironia, nel far individuare il nodo problematico allo stesso avversario, rigoroso e terribile allo stesso tempo nel farlo impietosamente ritrattare per poi indurlo a richiedere di essere illuminato. Poi, onestamente, si perdeva, forse perché dietro la sua figura si nascondeva il pensiero di Platone, e si permetteva di fornire argomentazioni suggestive ma deboli dal punto di vista strettamente argomentativo; se Socrate avesse avuto la possibilità di incontrare se stesso avrebbe demolito anche le sue certezze. Ma quello non era Socrate, appunto, era Platone che cercava di dare importanza alle sue elucubrazioni mentali.
Ecco si può distruggere qualcuno, fornendo dati poco circostanziati ma in qualche modo convincenti: chi conosce la filosofia platonica, sicuramente non prenderà sul serio le mie affermazioni precedenti, ma chi non sa potrebbe convincersi che in fondo quel Platone fosse un gran cialtrone!
Le cose fortunatamente non sono mai così semplici, quando si tratta di filosofia.
In effetti si può rileggere la storia della filosofia come storia della demolizione progressiva del pensiero dei predecessori, oppure, forse in modo più efficace, come storia dello scontro dialettico tra i sapienti di ogni tempo.
Facciamo degli esempi: distruggere l’Aristotele degli aristotelici di cui si faceva beffa Galilei, sarebbe come sparare sulla croce rossa, ma Aristotele è molto più difficile da demolire, perché è rigoroso come pochi e perché ha esplicitato il funzionamento del processo logico in maniera puntuale e quasi esaustiva, mentre i suoi seguaci tardo medievali, prescientifici e cristiani, avevano perso di vista l’attitudine aristotelica al confronto con l’oggetto di studio, rigorosa e metodica, e ne avevano idolatrato acriticamente i risultati: Ipse dixit!
Facendo un salto temporale potremmo cogliere il bersaglio grosso con il più strambo degli empiristi, il Berkeley di “Esse est percipi”, facile perché lo prendevano in giro anche i colleghi dei suoi tempi, ma poi la fisica quantistica, la più avveniristica e problematica intuizione della fisica contemporanea, ti dice che il comportamento della particella quantistica viene influenzato dall’osservatore, riconoscendo che talvolta l’essere può essere determinato dalla percezione.
Poco prima di Berkeley, Francis Bacon aveva parlato apertamente di pars destruens del sistema, scagliandosi contro i pregiudizi che avevano minato dall’interno il sapere fino ai suoi tempi. Lui li chiamò idola, e fu bravissimo a cogliere le fallacie dell’apparato culturale del sistema aristotelico/tolemaico/cristiano, ma si perse anche lui quando si trattò della pars construens del suo sistema, la quale tuttora viene considerata meno interessante della prima.
La realtà è che i filosofi sembrerebbero, a una lettura superficiale, tutti un po’ cialtroni, ma il loro grande pregio è che hanno insegnato l’attitudine critica che ci fa riconoscere una cialtroneria quando si fa avanti, con l’assunto però che, prima o poi, questa cialtroneria possa assumere un senso nuovo se viene osservata da un punto di vista differente. Quindi si distrugge, si crea e si distrugge in una continua dialettica che poi, alla fine, è il sale del sapere umano.
Allora possiamo concludere che la distruzione è un metodo, è un approccio alle cose che sono chiuse e apparentemente blindate, l’unico sistema per scardinare certezze che forse non hanno più senso, il solo compito sensato che la filosofia ci assegna ancora oggi, ma non deve essere una distruzione superficiale, bisogna penetrare le difese dialettiche che ogni buon sistema prevede, scardinarle in modo efficace e, infine ribaltarle. Il progresso, se di progresso ha senso parlare oggi, è provare a costruire partendo dalle macerie, recuperando le pietre angolari, usando materiali più tecnologici, cercando di fare qualcosa che abbia la capacità di durare nel tempo, sapendo che prima o poi qualcuno troverà il modo di demolirlo.