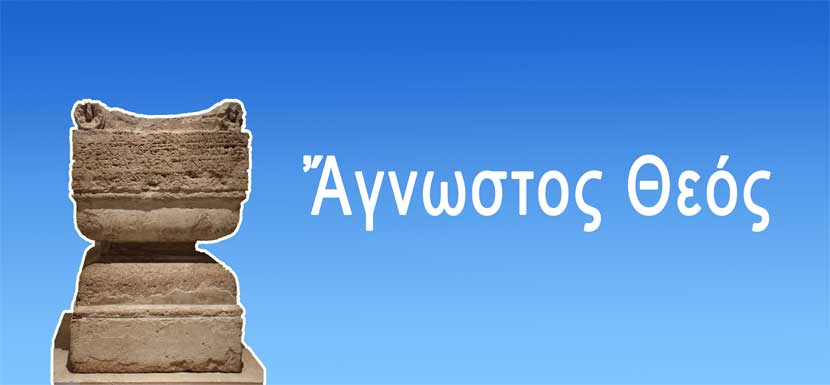
Qualche anno fa, a Catania, stavo curiosando in una bancarella di libri usati – di quelli che si possono portare a casa a due o tre euro al massimo – e mi sono imbattuto in un titolo della collana editoriale “Biblioteca Universale Rizzoli”: Trans-Europa Express. Una lettura che non ho mai dimenticato. Si trattava di una raccolta di brevi saggi e racconti di autori provenienti da diversi paesi europei.
L’idea del libro suppongo fosse quella di tracciare – attraverso un’attenta selezione e organizzazione dei suoi contributi – un sentire, una categoria di esperienze e una cornice valoriale che potessero considerarsi propriamente (e fieramente) europei. Devo dire che l’impressione che mi è rimasta, anche a distanza di anni da che ho finito di leggerlo, è che tutto sommato ci siano riusciti.
Mi aveva colpito, in particolare, la riflessione di uno scrittore ungherese (di cui purtroppo non ricordo più il nome) che ruotava attorno al concetto di Dio Sconosciuto (Ágnostos theós): una divinità per l’appunto ignota alla quale gli antichi Ateniesi usavano dedicare, accanto alle statue in pompa magna degli altri celebri rappresentanti del loro pantheon, un piedistallo che lasciavano curiosamente, ma opportunamente, vuoto.
L’autore, ricordo, era rimasto davvero entusiasta (e io con lui) di questa meravigliosa intuizione…
A un livello più superficiale, pare che il popolo ateniese avesse escogitato questo stratagemma per scongiurare l’eventualità di far adirare divinità antichissime, nel frattempo dimenticate e dunque impossibili da rappresentare e venerare, oltre a divinità non ancora conosciute o scoperte. In questo modo, riservando alla totalità di questi dei ignoti un piedistallo vacante, si assicuravano il beneplacito dell’intero universo divino.
Ma a colpire è soprattutto un’implicazione di natura filosofica, molto sottile, che questa usanza sembra rilevare a una più attenta analisi: l’uomo non può avere la pretesa di comprendere ed esaurire tutti gli aspetti della realtà che lo circonda.
Si tratta, a mio avviso, di una conquista straordinaria, degna di un popolo raffinato come quello degli antichi Ateniesi, e che ha a che fare con un altro concetto proprio di tutta la cultura greca, quello di hỳbris. Questa parola indicava precisamente la superbia, la scellerata tracotanza per mezzo della quale l’uomo si metteva in testa di sfidare gli dei o di ergersi a loro pari.
In questo senso, il piedistallo vuoto rappresenta un’umile ammissione dell’insufficienza umana e, allo stesso tempo, l’atto fondativo di uno spazio metafisico impossibile da colonizzare: una viva sorgente da cui possano scaturire inedite possibilità dell’esistere, del sentire e del comprendere il mondo.
Verrebbe da dire che noi Europei abbiamo riscoperto questo spazio soltanto di recente, anche grazie al contributo di scoperte scientifiche come la meccanica quantistica, e dopo secoli di sterile determinismo, positivismo e una buona dose di horror vacui.
Tuttavia, l’uomo di oggi non deve cadere nella tentazione, stavolta tutta post-moderna, di porre sopra a quel piedistallo non già il nulla come possibilità, così come avevano inteso di fare gli antichi Ateniesi, bensì il nulla come negazione assoluta, sprofondando nel baratro del non-senso che rende ogni vita indegna di essere vissuta, oltre che illegittimo e inefficace ogni tentativo di fondare o giustificare l’esistenza di una società civile.