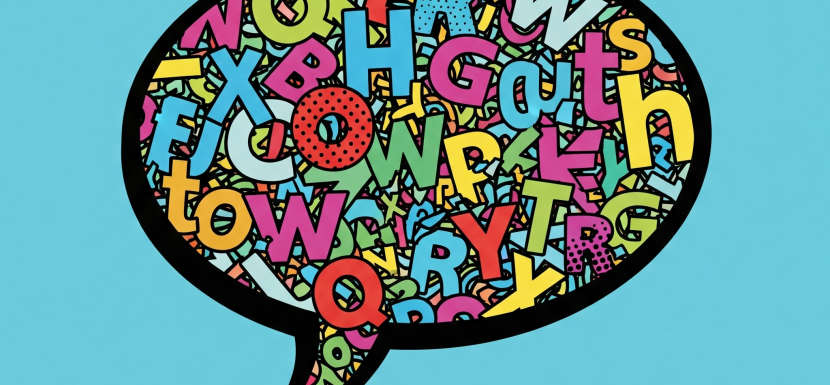
L’essere umano si distingue dagli altri animali perché dotato di LOGOS. Questa parola del greco antico traduce un ventaglio di significati apparentemente diversi fra loro, ma in realtà fortemente connessi. Logos significa parola, discorso, ma anche pensiero e comunicazione. Per i filosofi, racchiude l’essenza e il divenire delle cose, per la dottrina cristiana è il Verbo, il principio divino che si fa uomo in Gesù Cristo.
Il poter parlare e poi scrivere, quindi, ha implicito in sé il senso stesso della vita, che a sua volta risponde a un ordine razionale (logos=pensiero) e si concretizza nel momento in cui è organizzata e comunicata.
Mi perdoneranno, i filologi, i linguisti, i filosofi, se ho sintetizzato in una manciata di righe un concetto più denso dell’osmio, ma la mia brevissima introduzione è finalizzata a una sola causa: convincere i miei lettori a non sottovalutare l’importanza della costruzione della frase e, quindi, del periodo. E perché frase e periodo possano avere una costruzione inespugnabile è importante padroneggiare l’analisi logica e del periodo.
Ecco, ricomponetevi, dopo il tonfo dalla spiaggina sulla quale mollemente adagiati scrollate il vostro smartphone alla ricerca di qualcosa da leggere. Non è mia intenzione rovinarvi la siesta salmastra suscitando reminiscenze dei tempi di scuola. Certo è che – e ne sono convinta – se a scuola si studiassero davvero bene benissimo le analisi di cui sopra, il mondo sarebbe un posto più ordinato, razionale, nitido. Vediamo come.
La costruzione di una frase semplice prevede l’utilizzo di un verbo, che distinguiamo in predicato verbale e predicato nominale. Quest’ultimo è solo il verbo essere quando è accompagnato da una parte nominale che predica qualcosa sul soggetto. Solo ed esclusivamente il verbo essere. Tutti gli altri confluiscono nella definizione di predicato verbale, anche quando somigliano molto all’utilizzo nominale del verbo essere. Mi spiego meglio.
Analizziamo la frase semplice “io sono simpatica”: io è il soggetto; sono simpatica è invece il predicato nominale, composto da una copula (sono) e dal nome del predicato (simpatica, che è un aggettivo, in questo caso). Se cambio questa frase semplice in una molto somigliante, cambia la nomenclatura, ma non il senso. Nella frase “io sembro simpatica”, abbiamo io come soggetto, sembro come predicato verbale e simpatica come complemento predicativo del soggetto. Quest’ultimo equivale paro paro (ma se vi concentrate un attimo, lo percepite a prescindere dalle mie parole) al nome del predicato di cui sopra. E il verbo, anche se è chiamato qui predicato verbale, assolve alla medesima funzione del verbo essere di prima, solo che sottolinea una sfumatura diversa: io sembro, non io sono. Però i linguisti sono capricciosi, quindi il nome di predicato nominale va solo al verbo essere. Tutti gli altri sono predicati verbali.
Nei predicati verbali confluiscono i verbi transitivi e quelli intransitivi. Gli intransitivi sono quei verbi il cui significato non si completa con un complemento oggetto. I verbi di movimento, per esempio. Tranne al sud Italia, entrare e uscire non vogliono un oggetto dopo di loro. E nemmeno salire e scendere, se non il loro oggetto interno (scale, pendii, etc etc). Anche i verbi esistenziali sono intransitivi: nascere, crescere, vivere, morire et similia. Ecco, i verbi intransitivi possono avere invece il complemento predicativo del soggetto: io posso salire stanca o posso nascere povera, come posso crescere simpatica o scendere trafelata.
Invece, i verbi transitivi sono quei verbi che da soli stanno benone, ma se seguiti da un complemento oggetto specificano il loro significato. Per dire, io mangio. E fin qui, non ci piove. Sto esprimendo il significato del verbo nel suo senso lato, esteso, intransitivo. Sto esprimendo una mia attitudine o abitudine o predestinazione. Se invece aggiungo un complemento oggetto, io mangio una mela,sto volendo comunicare una situazione più specifica del mangiare in generale, sto circoscrivendo la mia azione, sto spiegando al mondo la tristezza della dieta dimagrante con l’atto di mangiare il frutto più citato della storia dell’umanità.
Attorno ai verbi, ruotano i famigerati complementi, incubo di generazioni di ragazze e ragazzi; in realtà, non sono poi così spaventosi: sono i mattoncini logici con i quali costruiamo la frase. I principali, cioè quelli strettamente vincolati al verbo senza alcuna mediazione, sono i complementi diretti: soggetto e complemento oggetto. Possono non esserci, nella frase, ma quando ci sono, hanno un legame molto stretto con il predicato verbale. Il soggetto influenza il numero e la persona (a volte anche il genere, se il predicato è composto da participi) del predicato verbale. Il complemento oggetto, invece, completa il significato del verbo. Come nel caso di cui sopra, quello della mela.
A corolla, come in un fiore ben rimpolpato, ci stanno tutti gli altri complementi. Sono degli accessori, delle informazioni in più alla dinamica della frase semplice, che sarebbe già più che completa con soggetto e complemento oggetto. Però l’uomo possiede il Logos, e poi è proprio portato per comunicare, quindi tende ad abbellire la frase con notizie utili a definire meglio il messaggio, e utili al ricevente per decifrarlo.
Quindi, a questo punto, a me piace dividere i complementi in tre grossi gruppi, dai quali sono davvero molto pochi quelli che sfuggono. Ci sono i complementi fermi, hic et nunc, quelli che specificano un posto o un luogo: il complemento di stato in luogo e il complemento di tempo determinato. Spazio e tempo sono indicati in modo preciso, nonostante essi possano contenere approssimazioni. Due esempi: vivo in un paese sconfinato; ci vediamo più o meno alle dieci. Approssimazioni, ma determinate.
Poi ci sono i complementi di provenienza: d’origine, di moto da luogo, d’agente, di causa efficiente, di materia… Sono complementi collocabili nel significato del provenire, proprio. Sono così imparentati fra loro, che in latino e in greco antico si esprimono allo stesso modo, spesso. Peccato che difficilmente vengano spiegati così, ma quando i ragazzi lo scoprono, è come si si aprisse loro un mondo. Su una linea immaginaria da sinistra a destra, questi li mettiamo in movimento e li vediamo arrivare nella nostra frase: indicano tutti degli incipit, delle partenze, un principio.
In ultimo – in questa disamina, non nella sintassi della frase, ché ce ne sarebbero cose da dire… – ci sono i complementi che io chiamo in uscita. Sono quelli proiettati verso avanti, verso il futuro. Mentre quelli di prima arrivano nella frase, questi – sempre in movimento – li vediamo scivolare via verso destra: il complemento di moto a luogo, il complemento di fine… Anche questi hanno la medesima costruzione perché hanno il medesimo intento, cioè quello di stare proiettati verso un luogo, reale o metaforico che sia. Il fine cos’è, se non il desiderio di andare verso qualcosa/qualcuno?
La sintassi della frase, quella che abbiamo – bene o male – imparato studiando l’analisi logica sin dalle scuole medie – non si esaurisce certo in queste due paginette, ma offre una vastissima gamma di combinazioni (logiche, appunto) perché la comunicazione risulti ricca ed efficace. Chi si appropria degli strumenti logici per la costruzione della frase e poi del periodo (composto da più frasi), chi li padroneggia e non si lascia sopraffare coltiva la propria logica, il proprio pensiero, la propria capacità di analisi.
No, non è importante sapere come si chiami questo o quel complemento o il nome del gruppo del verbo che stiamo usando: è importante aver bene chiaro in mente i loro utilizzi, per piegare la sintassi al proprio servizio e farne l’arma migliore di cui l’uomo possa disporre: la sua ragione.
Arma, in senso buono. Matri.
Maria Giovanna, condivido parola per parola, oltre alla sintassi e alla punteggiatura.
Aggiungerei quello che ricordo sempre alle mie studentesse e ai miei studenti, che la parola “poesia” in greco è legata all’atto del produrre. È la parola,dunque, che ci rende “simili a Dio”. Ritengo quindi sacrosanto quello che tu scrivi, perché utilizzando bene le parole, organizzandole in maniera sintatticamente corretta, riusciamo a comunicare con gli altri. Non sopporto, quando faccio notare che un periodo è poco chiaro, che mi si dica: “io capisco quello che ho scritto ” . Grazie, Maria Giovanna: tu sento vicina nella mia battaglia.
Grazie per il tuo contributo, cara Lilla